ARTICOLI
Allenati duro… ma odiati di piU’? Come l’assenza di autocompassione distrugge la performance
- 1 settembre 2025
- Posted by: carlotta.ferrari01
- Categoria: Articoli
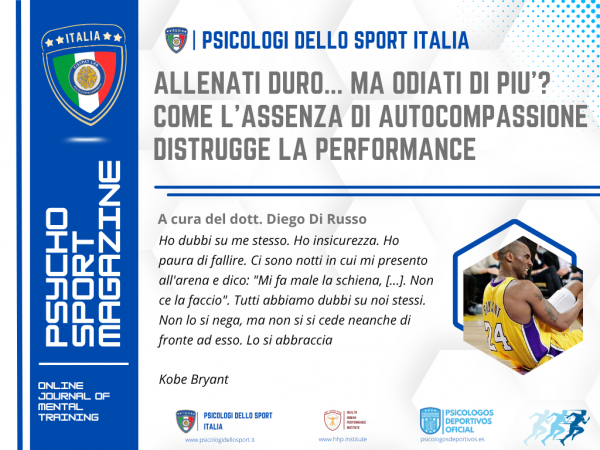
Negli ambienti sportivi agonistici, le emozioni degli atleti sono spesso gestite in modo controverso. Tradizionalmente si è diffusa una mentalità di “toughness”, secondo cui mostrare vulnerabilità o ammettere difficoltà emotive è segno di debolezza. Questo ha contribuito a radicare una cultura tossica delle emozioni nello sport, in cui la sofferenza psicologica viene stigmatizzata o ignorata. In questi contesti, l’obiettivo di vincere medaglie ha avuto la precedenza sul benessere psicologico, creando un clima in cui gli atleti esitano a chiedere aiuto o a esprimere il proprio disagio. Tale cultura, viene inoltre riscontrata nelle riportate esperienze di abuso emotivo dei coaches verso atleti. Fra i comportamenti più frequenti, atleti riportano, “urli”, “umiliazioni” e “denigrazioni” (Gervis & Dunn, 2004). Ad esempio, atleti riportano «(l’allenatore) mi spaventava molto; avevo paura di fare qualsiasi cosa perché, qualunque cosa facessi, per lui era sbagliata e mi urlava contro» (Gervis & Dunn, 2004). Ciò conduce gli atleti a riferire di sentirsi “stupidi”, “senza valore”, “arrabbiati”, “in colpa”, “depressi”, “umiliati”, “addolorati”, “inferiori”, “sconvolti” e “mancanti di fiducia in se stessi”. Oltre alla cultura in cui questi coaches possono essere stati allenati, varie ragioni sottendono questi comportamenti. Ad esempio, considerando che la reputazione, oltre che le entrate economiche, dei coaches viene costruita in funzione dei risultati ottenuti dagli atleti, i coach hanno «molto di più da perdere se l’atleta non ottiene il successo risultato», portandoli ad adottare approcci di “vincere a ogni costo” (Gervis & Dunn, 2004). Questo focus eccessivo sulla performance attraverso la “durezza” non può che creare una situazione paradossale di ridotto divertimento e apprezzamento dello sport e dell’allenamento, portando ad aumentato rischio di burnout e dropout (Yperen et al., 2022), e, in ultimo luogo, minore frequenza e/o intensità di allenamenti e performance. A tal proposito, Lundqvist e colleghi (2025) hanno recentemente investigato le conseguenze della leadership tossica sulla salute mentale e performance degli atleti, riportando effetti negativi sulla prima, insieme ad un effetto negativo su infortuni e motivazione. In questo contesto, la psicologia dello sport sta esplorando approcci alternativi per promuovere la salute mentale senza compromettere la competitività. Uno di questi è il concetto di autocompassione (self-compassion), che rappresenta un modo sano di rapportarsi a se stessi nelle situazioni di stress e fallimento. Difatti, attualmente, questa cultura negli atleti si riflette con severa autocritica, giudizio severo verso se stessi e ruminazione nel caso di fallimento (Zhang et al 2023). È diffusa la credenza che questo modo di relazionarsi con loro stessi sia “necessario” per raggiungere la massima performance, e che, se non lo facessero, diventerebbero compiacenti e fallirebbero nel raggiungere il loro massimo potenziale. Questo non può che portare ad una effettiva “paura” dell’autocompassione.
Ciò che spesso non viene considerato in questo contesto è il ruolo che questa cultura ha nell’ostacolare la performance, portando, ad esempio, a peggiore autoregolazione, gestione dello stress e ridotta performance (Zhang et al., 2023). Allo stesso modo, non viene considerato il ruolo dell’autocompassione nel promuovere la performance.
L’autocompassione
Come uno dei principali ricercatori in questo campo, Neff (2003) definisce l’autocompassione come la modalità attraverso cui gli individui si «relazionano con loro stessi nelle situazioni di percezione di fallimento, inadeguatezza, o sofferenza personale». L’autore delinea 3 componenti principali dell’autocompassione
- Gentilezza verso sé stessi: Essere comprensivi e non giudicanti nei propri confronti quando si commettono errori o si affrontano momenti difficili, invece di essere autocritici o severi
- Umanità condivisa: Riconoscere che la sofferenza e l’imperfezione sono parte della condizione umana e che non si è soli nelle proprie difficoltà
- Mindfulness (consapevolezza): Mantenere una consapevolezza equilibrata delle proprie emozioni dolorose, senza reprimerle né lasciarsi travolgere da esse
La cultura attuale porta gli atleti a temere l’autocompassione, credendo che questa porti a compiacenza e a mediocrità (Mosewich, 2020). Anche gli anziani sono in accordo, definendo l’autocompassione come una «st*****ta dell’epoca moderna, qualcosa che le persone giovani hanno creato per stare meglio con loro stessi, e che non funzionerà» (Bennett et al., 2017) . Nonostante tale timore possa apparire sensato alla luce della cultura sportiva attuale, più di 20 anni fa, Neff (2003) aveva già anticipato questa preoccupazione, evidenziando come fossero invece i bassi livelli di autocompassione, accompagnati da un’elevata autocritica, a condurre maggiormente alla passività. Infatti, individui altamente autocritici tendono più facilmente ad evitare il confronto con i problemi e ad avere difficoltà nella gestione efficace delle proprie emozioni e dei sentimenti negativi. Diversamente, atleti con alta autocompassione sono meno a rischio di procrastinare e tendono maggiormente ad assumersi la responsabilità per i propri errori e fallimenti rispetto ad atleti con bassi livelli di autocompassione (Mosewich, 2020). Forse in modo ancora più convincente, i risultati evidenziati da Ferguson et al. (2015) mostrano come avere paura dell’autocompassione sia legato a maggiori reazioni ruminative, passive e autocritiche. Diversamente, bassi livelli di paura dell’autocompassione risultano legati a reazioni positive, responsabili e perseveranti, legate ai concetti di “Striving”(impegno, sforzo) e “Grit” (grinta, tenacia), acclamati nella cultura sportiva (Duckworth, 2017; Russell, 2020). In generale, la compassione risulta legata cognizioni, comportamenti e emozioni ritenute benefiche per lo sport e la performance (Mosewich, 2020). A tal proposito, interventi mirati ad aumentare l’ autocompassione hanno mostrato, rispetto ai gruppi di controllo, maggiore performance sportiva percepita (Kuchar et al., 2023) nei gruppi sperimentali, insieme ad un effetto predittivo sullo stato di flow (Lyon & Plisco, 2020).
In conclusione, l’introduzione dell’autocompassione nella preparazione psicologica degli atleti potrebbe rappresentare una svolta fondamentale. Gli allenatori e gli atleti stessi dovrebbero essere sensibilizzati e formati per comprendere che la vera resilienza non deriva dalla durezza emotiva, ma dalla capacità di affrontare le difficoltà con empatia verso sé stessi e verso gli altri. Tale cambiamento migliorerebbe non solo la salute mentale degli atleti, ma anche il loro rendimento e la loro longevità nello sport.
A cura del Dott. Diego Di Russo
Alessandro Bargnani CEO
Bibliografia
- Bennett, E. V., Clarke, L. H., Kowalski, K. C., & Crocker, P. R. E. (2017). “I’ll do anything to maintain my health”: How women aged 65–94 perceive, experience, and cope with their aging bodies. Body Image, 21, 71–80. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2017.03.002
- Duckworth, A. (2017). Grinta. Il potere della passione e della perseveranza (A. Bottini, Trans.). Giunti. (Opera originale pubblicata nel 2016).
- Gervis, M., & Dunn, N. (2004). The emotional abuse of elite child athletes by their coaches. Child Abuse Review, 13(3), 215–223. https://doi.org/10.1002/car.843
- Kuchar, A. L., Neff, K. D., & Mosewich, A. D. (2023). Resilience and Enhancement in Sport, Exercise, & Training (RESET): A brief self-compassion intervention with NCAA student-athletes. Psychology of Sport and Exercise, 67, 102426. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2023.102426
- Lundqvist, C., Camps, J., Vertommen, T., Barker-Ruchti, N., & Kolbeinsson, Ö. (2025). Toxic leadership in high-performance sports and its consequences for mental health and performance: a scoping review. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1–27. https://doi.org/10.1080/1750984X.2025.2457038
- Lyon, N., & Plisco, M. (2020). The effects of self-compassion and mindfulness on performance anxiety and flow in elite athletes. Journal of Sport Behavior, 43(4), 426–441.
- Mosewich, A. D. (2020). Self-compassion in sport and exercise. In G. Tenenbaum & R. C. Eklund (Eds.), Handbook of sport psychology (4th ed., pp. 158–177). Wiley.
- Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2), 85–101. https://doi.org/10.1080/15298860309032
- Russell, J. S. (2020). Striving, entropy, and meaning. Journal of the Philosophy of Sport, 47(3), 419–437. https://doi.org/10.1080/00948705.2020.1789987
- Van Yperen, N. W., Jonker, L., & Verbeek, J. (2022). Predicting dropout from organized football: A prospective 4-year study among adolescent and young adult football players. Frontiers in Sports and Active Living, 3, 752884. https://doi.org/10.3389/fspor.2021.752884
- Zhang, N., Huang, J., & Yao, J. (2023). Athletes’ self-compassion and emotional resilience to failure: The mediating role of vagal reactivity. Frontiers in Psychology, 14, 1192265. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1192265




 Informazioni Consulenza
Informazioni Consulenza